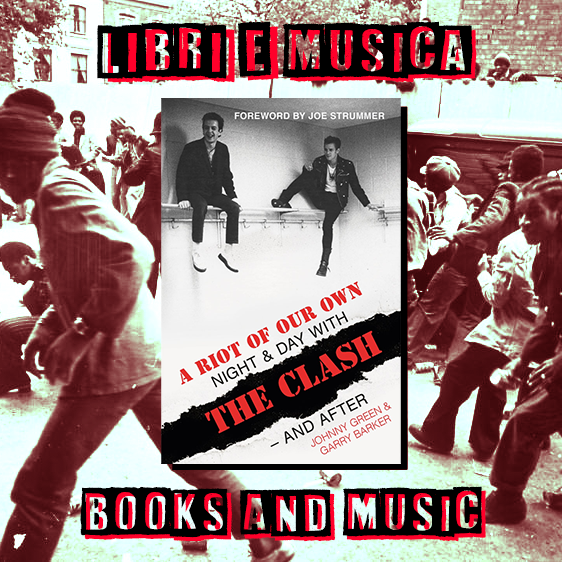Quando a 14 anni iniziai ad addentrarmi nella magica rete di musica e gossip del Britpop, i Suede erano uno dei gruppi che tendevo ad accantonare di più: nonostante facessero parte dei cosiddetti big four fondamentali assieme a Blur, Pulp e Oasis, per qualche motivo non mi attiravano granché. Non che li ignorassi del tutto – adoravo canzoni come Beautiful Ones e Animal Nitrate -, ma a distanza di anni credo che il mio scetticismo fosse dovuto principalmente al mio amore sconfinato per i Blur e all’influenza che su di me esercitavano tutti quei pettegolezzi che avevo assorbito sulla tensione romantica e le gelosie tra Brett Anderson, Justine Frischmann e Damon Albarn: nonostante la seconda avesse scaricato il primo per mettersi col terzo, per qualche meccanismo distorto del mio cervello adolescente, nella spettacolarmente infantile rivalità tra i due frontman, per me il cattivo era Brett. Poi sono cresciuta, ho imparato a indirizzare il mio astio verso il complesso di onnipotenza dei fratelli Gallagher, ho scoperto che Brett Anderson non era poi così antipatico come credevo e che i Suede erano davvero fighissimi. Che cosa mi ero persa…
I primi mesi di quest’anno li ho dedicati a recuperare parte della loro discografia, con un interesse alimentato dalla lettura di Lunch With The Wild Frontiers di Jane Savidge, l’addetta alle pubbliche relazioni che negli anni novanta – tra le tante cose – ha curato il modo in cui la stampa doveva parlare dei Suede, già definiti “migliore nuova band britannica” prima ancora di pubblicare qualsiasi singolo. I loro primi tre album in particolare sono diventati un’irrinunciabile colonna sonora, ho guardato il documentario The Insatiable Ones dividendolo in piccoli capitoli per evitare che finisse troppo presto, ho iniziato a commuovermi anch’io alla centesima visione del concerto alla Royal Albert Hall nel 2010 e ho creato una bacheca su pinterest esclusivamente dedicata a Brett Anderson che qualunque studente di moda potrebbe invidiarmi. (Una ricerca condotta con tale entusiasmo ha anche i suoi lati negativi, come il fatto che tutt’ora non c’è giorno che passi senza che il ritornello di The Drowners mi risuoni nel cervello totalmente senza preavviso, ma questi sono rischi inevitabili). Poi ho scoperto che Brett ha scritto non una, ma ben due autobiografie, e quella è stata la ciliegina sulla torta.

Il primo libro è Coal Black Mornings e ripercorre gli anni dall’infanzia agli esordi dei Suede – “prima che qualcuno sapesse o gliene importasse davvero” –, ma non si tratta della solita opera autocelebrativa: infatti, si tratta soprattutto di un regalo da parte di Anderson al figlio Lucian, un documento che un giorno lo aiuterà a capire meglio quali siano le sue radici e a conoscere davvero la giovinezza del padre; proprio per questo, Brett concentra le sue energie narrative sul ricordo di anni caratterizzati da fallimenti, ansie, lutti, ma anche dall’amore e dall’amicizia. La sua è stata un’infanzia segnata dalle continue difficoltà economiche e dalla rigida, a tratti disumana, educazione scolastica degli anni 70: descrive con dovizia di particolari la minuscola casa di Haywards Heath, gli arredi e i quadri alle pareti della madre artista, la tragicomica personalità del padre e i suoi mille lavori per mantenere la famiglia, il legame con la sorella maggiore, le cene a base di carne stopposa, gli spiccioli racimolati con i primi lavoretti deprimenti, l’umiliazione di sfilare davanti ai compagni di scuola in mensa in quanto fruitore di pasti gratuiti. In mezzo a questi ricordi di povertà emergono con particolare forza i racconti legati ai genitori, due personaggi imponenti e complessi con caratteri molto differenti: da un lato la madre Sandra, tenera, accogliente, apprensiva, amante della natura e con una creatività senza limiti; dall’altro il padre Peter, eccentrico, imprevedibile, paranoico, ossessionato dalla musica classica e che convinceva la famiglia a stiparsi nella traballante Morris Traveller in pellegrinaggio estivo in Austria nei luoghi di Franz Liszt. Brett ritrae questi quadretti di vita familiare con affetto e riconoscenza, ma anche con un certo distacco che gli permette – nei momenti di autoanalisi – di identificare le radici di alcuni suoi tratti caratteriali e abitudini. Tra i temi centrali vi sono il rapporto padre-figlio e i traumi generazionali: colpiscono la compassione e la maturità con cui Anderson racconta e accetta la figura paterna, riconoscendo a distanza di anni che molti suoi lati problematici erano fondamentalmente il risultato di un’infanzia anaffettiva e violenta con un genitore alcolizzato, e che Peter cercò con i pochi mezzi (e i pessimi esempi) a propria disposizione di fare in modo che i figli non dovessero crescere nella paura.

Il look austero dei Suede mi ha sempre ingannata, facendomi pensare che fossero una band snob e sofisticata di agiata estrazione borghese; ma leggendo Coal Black Mornings ho dovuto decostruire questa impressione così radicata nella mia mente. Come spesso accade, la noia e l’alienazione della periferia costituiscono terreno fertile per gli spiriti creativi, e Brett Anderson non si è certamente tirato indietro quando si è trattato di uscire dalla sua condizione di isolamento: la scoperta del punk – in particolare i Sex Pistols – ha rappresentato il primo barlume di speranza, una forza dirompente che spingerà Brett verso l’ambizione di fare musica e soprattutto fuori dai confini asfissianti di Haywards Heath. Procedendo nella lettura, Anderson ci guida in un ipotetico percorso tra i testi che andranno a comporre l’album di debutto dei Suede, fortemente ispirati dai cambiamenti, dai traumi e dalle esperienze di questo periodo di transizione: sono brani che parlano di emarginazione, di disoccupazione, di sessualità, di trasgressione, di rabbia, di dolore e di perdita. Ogni traccia è legata ad un preciso aneddoto, dimostrando quanto sia innata in Brett la capacità di osservare e raccontare la vita in tutti i suoi aspetti più inusuali, introspettivi e marginali.
Nel trasferimento dalla periferia a Londra, la storia si arricchisce di nuovi personaggi: tra questi, oltre ai futuri compagni di band Mat Osman, Simon Gilbert e Bernard Butler, centrale è la figura di Justine Frischmann – elegante, intelligente, affascinante e il primo amore di Anderson. La loro sarà una relazione breve ma intensa, due persone socialmente agli opposti ma con un’intesa fortissima che sarà fonte di un’inarrestabile foga artistica; eppure la loro (triste) rottura, paradossalmente, darà ai Suede la spinta definitiva di cui avevano bisogno per definire la propria identità e sfondare.
La storia si chiude nel momento in cui la band firma il suo primo contratto. Brett delinea magistralmente questo senso di sospensione, di eccitazione e di speranza: riusciamo a immaginarceli benissimo questi quattro ragazzi, il loro pallore esaltato dal sole invernale fuori dall’ufficio discografico, euforici e anche un po’ confusi. Li attendono anni difficili ma loro ancora non lo sanno, perché ciò che conta è che quell’imbarazzante “spazio a forma di D” davanti al palco non sia più vuoto. Finalmente, è tempo di lasciarsi alle spalle le mattine nere come il carbone.